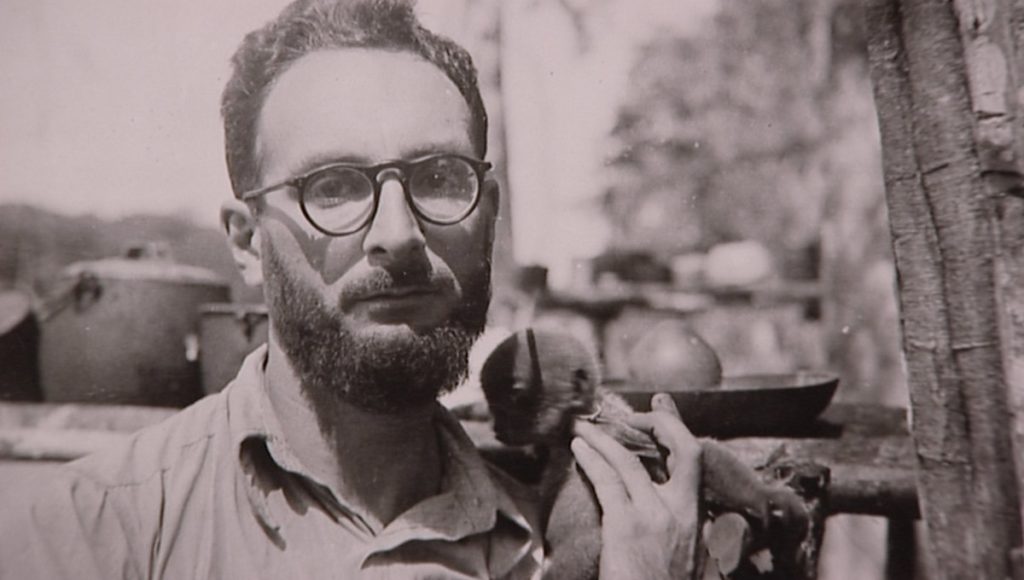“Chi è l’essere umano?” è uno degli interrogativi a cui gli studiosi di scienze umane cercano di rispondere da sempre, ma i tentativi variano di continuo e seguono filoni scientifici differenti, complementari. Antropologia ed educazione, a tal proposito, si trovano spesso a viaggiare insieme nel tentativo di rispondere a questo quesito.
Prima di partire…
Il primo riferimento da cui far partire la commistione di approcci è la Grounded Theory ideata da Glaser e Strauss, i quali pubblicarono il volume “The discovery of Grounded Theory” nel 1967, definendola come “un metodo generale di analisi comparativa e un insieme di procedure capaci di generare sistematicamente una teoria fondata sui dati”.
Si trattava di un metodo che risentiva delle tre principali tradizioni di ricerca qualitativa: l’etnografia, la fenomenologia e l’interazionismo simbolico. L’obiettivo più ambizioso della sociologia è quello di cercare di comprendere la differenza tra l’essere umano e gli animali, mentre lo scopo minimo è provare a descrivere ciò che compie.
Antropologia ed educazione: le scienze dell’uomo
L’antropologia è una disciplina recente, ma ad essa fanno riferimento moltissimi altri ambiti di ricerca ed è proprio questo a renderla antichissima. Il termine deriva dal greco ànthropos ‹‹uomo›› e lògos ‹‹discorso, dottrina››, ma la sua ufficializzazione avvenne nell’Ottocento con Morgan Tylor e Marc Augé. Quest’ultimo affermava che l’antropologo non facesse altro che discorrere di quanto accadeva sotto agli occhi di tutti. Fino a quel momento, tuttavia, vi era solamente una sorta di “antropologia implicita”.
Nel 1871 Edward Tylor coniò la definizione di “cultura”, intendendola come l’insieme delle conoscenze, delle credenze, dell’arte, della morale, della legge, del costume e di ogni altra capacità o usanza acquisita dall’essere umano come appartenente alla società. Il riferimento al patrimonio culturale è qui dovuto, in quanto esso comprende l’insieme delle conoscenze che vengono trasmesse di generazione in generazione, contribuendo al processo di incorporazione e/o apprendimento, ma anche alle fasi si socializzazione primaria e secondaria. A differenza della filosofia, l’antropologia utilizza il metodo induttivo: dal particolare al generale, cercando di comprendere il modo attraverso cui un individuo viene plasmato dalla cultura, ma anche come esso contribuisca ad arricchirla.
L’antropologia, infatti, viene pure definita “etnologia”, in quanto è un termine che rinvia alle usanze e alle credenze che nascono e si diffondono nei popoli. Questi sono influenzati inevitabilmente dall’ambiente in cui risiedono, in quanto da sempre l’essere umano cerca di sopravvivere ad esso, adattandolo alle sue esigenze e lasciandosi plasmare. Le scienze umane non potrebbero non essere considerate “scienze molli”, poiché non esatte come la matematica, né certe. Esse devono sempre tenere in considerazione l’imprevedibilità della natura umana, relativa e plasmabile a seconda delle esperienze, dei vissuti soggettivi e collettivi.
Antropologia ed educazione
Il patrimonio genetico non sarebbe sufficiente per spiegare la natura dell’essere umano, in quanto la cultura viene appresa e tramandata dall’individuo più anziano all’individuo più giovane. Essa si adatta anche alle condizioni attuali, modificando quanto già esiste sulla base dell’esperienza. Per dimostrare come la cultura contribuisce a plasmare l’essere umano è possibile rifarsi al caso di Victor dell’Aveyron (1788 – 1828), cresciuto nei boschi del Massiccio centrale in Francia.
Le origini di questo ragazzo non furono mai rintracciate, ma sappiamo che nel 1801 venne preso a carico dal pedagogista Jean Itard, intenzionato a rieducarlo. Egli descriveva i modi e i comportamenti di Victor: mordeva, graffiava, grugniva, ringhiava e oziava rannicchiato in un angolo.
Itard pensò di donargli dei giocattoli idonei alla sua età (mostrava 12 anni) e di insistere col fornirgli stimoli volti alla sua rieducazione, ma Victor si mostrava immune al freddo e al caldo e utilizzava gli oggetti per appiccare il fuoco. Il ragazzo aveva alcuni sensi più sviluppati di altri, come il gusto, il tatto e l’olfatto, mentre la vista e l’udito e si attivavano solo in circostanze a lui familiari: forti nevicate, lo sgusciare delle castagne. Nel 1806 Itard rinunciò alla sua missione e si pentì di aver intrapreso quel percorso, condannando la sterile curiosità umana che aveva sradicato Victor dal suo posto. Il ragazzo, infatti, non cambiò mai. Questo aiuta a comprendere come l’uomo riesca a orientare i suoi istinti proprio grazie alla cultura, alla norma sociale e scritta, alle credenze condivise.
Antropologia e sistemi educativi
Nel corso del tempo l’antropologia ha dato un enorme contributo circa gli studi attorno ai sistemi educativi, avvalendosi sempre del metodo etnografico fatto di osservazioni partecipanti, interviste, video, registrazioni audio e trascrizioni, generando più prospettive: dal relativismo culturale – intenzionato a spiegare le azioni in relazione alla cultura d’appartenenza – al multiculturalismo, ma non si possono dimenticare i contributi di Franz Boas, Margaret Mead e Ruth Benedict.
Prima di procedere occorre precisare quanto affermava Clifford Geerz circa la cultura e l’identità: queste non devono intendersi come gabbie in cui imprigionare gli individui, ma come processi in continua trasformazione che si mantengono in equilibrio oscillando dalla solidarietà alla divisione. L’etnografia aiuterebbe a tracciare le miriadi di trasformazioni.
Antropologia ed educazione: la critica al positivismo
A criticare l’evoluzionismo e a difendere il relativismo fu Franz Boas (1858-1942), il quale si dedicò ad alcuni studi sull’isola di Baffin in Canada. Successivamente si trasferì negli Stati Uniti dove formò generazioni di studenti presso la Columbia University. Non scrisse veri e propri libri, ma diari colmi di descrizioni riguardanti gli Indiani dell’America del Nord, gli Inuit e i Kwakiutl della Columbia britannica.
Proprio grazie a queste sue osservazioni è riuscito a dimostrare che ogni comportamento e ogni elemento hanno senso solo nella loro cultura d’appartenenza. “Quali sono i processi psicologici che contribuiscono allo sviluppo di alcuni fenomeni culturali?” era una delle domande-guida di Boas. La prima donna nella storia dell’etnologia è stata Ruth Benedict (1887 – 1948), della quale ricordiamo “Modelli di cultura”. Ella condusse una ricerca sul campo e le sue tesi poggiavano sulla convinzione che la cultura non fosse altro che un insieme omogeneo, le cui caratteristiche segnassero gli appartenenti al gruppo.
Antropologia ed educazione: Ruth Benedict e Margareth Mead
Ogni bambino, infatti, condivide le abitudini, le attività, le credenze del gruppo sociale in cui vive e la cultura fornisce del materiale su cui costruire l’esistenza. Ruth osservò vari strutture sociali e sistemi educativi, riuscendo a descriverli accuratamente nelle loro rispettive differenze: gli Zuni del Sud-Ovest erano “apollinei”, in quanto sobri e pacifici, mentre i Kwakiutl dionisiaci, poiché competitivi e aggressivi. Infine, osservò i Dobu della Nuova Guinea, che erano tetri e vendicativi, privi di organizzazione politica e praticanti della magia a scopo malvagio.
Dopo l’attenta osservazione di alcuni immigrati giapponesi negli Statu Uniti, Ruth pubblicò “Il crisantemo e la spada” nel 1945, in cui fece valere nuovamente la sua tesi: i giapponesi sarebbero l’emblema dei misteri dell’Oriente, poiché aggressivi e pacifici, militaristi e poeti, coltivatori di crisantemi e abili nell’uso della spada. I modelli di vita sono necessari alla società umana e contribuiscono alla formazione del singolo.
Ricordiamo, infine Margaret Mead, allieva di Boas (1901 – 1978) che si occupò, nel corso delle sue ricerche in Nuova Guinea e a Bali, della socializzazione dei bambini, della sessualità e delle differenze tra uomo e donna. Approfondì, inoltre, anche numerosi studi circa l’adolescenza presso le Isole Samoa nella Polinesia, partendo da un interrogativo di fondo: “Le contrarietà che turbano i nostri adolescenti sono dovute all’adolescenza per se stessa o alla nostra civiltà?” L’adolescenza non è necessariamente un periodo fatto di tensioni e conflitti, ma il nostro sistema educativo deve attenersi alle condizioni di vita moderna e sono i suoi “fili intrecciati” a renderlo complesso nell’assimilazione.
Margaret Mead era giunta alla conclusione che presso le Samoa tutto era precostruito e questo non generava conflitti tra sistemi educativi (che invece sono molteplici nella società americana) e , di conseguenza, nelle persone.
Antropologia ed educazione: l’ambiente classe
Proprio attraverso l’osservazione partecipante condotta nei nostri sistemi educativi, ma anche con essi e attorno ad essi, è possibile rilevare il genere di società che si sta via via costruendo. Lo studio delle relazioni tra alunni e docenti, tra famiglia e istituzione può sicuramente avvalersi del metodo etnografico, prezioso strumento – come afferma Romanelli – per l’interculturalità.
Antropologia e pedagogia, infatti, hanno molto in comune, poiché entrambi scienze sociali, ma necessitano di un dialogo più approfondito rispetto a quello riconosciuto. Risulta urgente, infatti, porsi domande in relazione all’educazione informale, a quella che non avviene in luoghi in cui insegnamento e apprendimento non risultano essere le azioni principali (come la famiglia e gli amici).
Essa viene introiettata da bambini e adolescenti e, seppure in maniera involontaria, si manifesta in classe, luogo in cui i ruoli sono chiari e in virtù di questi s’intrecciano interazioni. L’ambiente classe – come tanti altri contesti – si configura come un prezioso laboratorio sociale in cui rilevare dati utili alla prevenzione di numerose problematiche giovanili attuali. Dopotutto, come affermava Alfred L. Kroeber, “l’antropologia è la più umanistica delle scienze e la più scientifica delle discipline umanistiche”.
Francesca Noemi Pia Carello