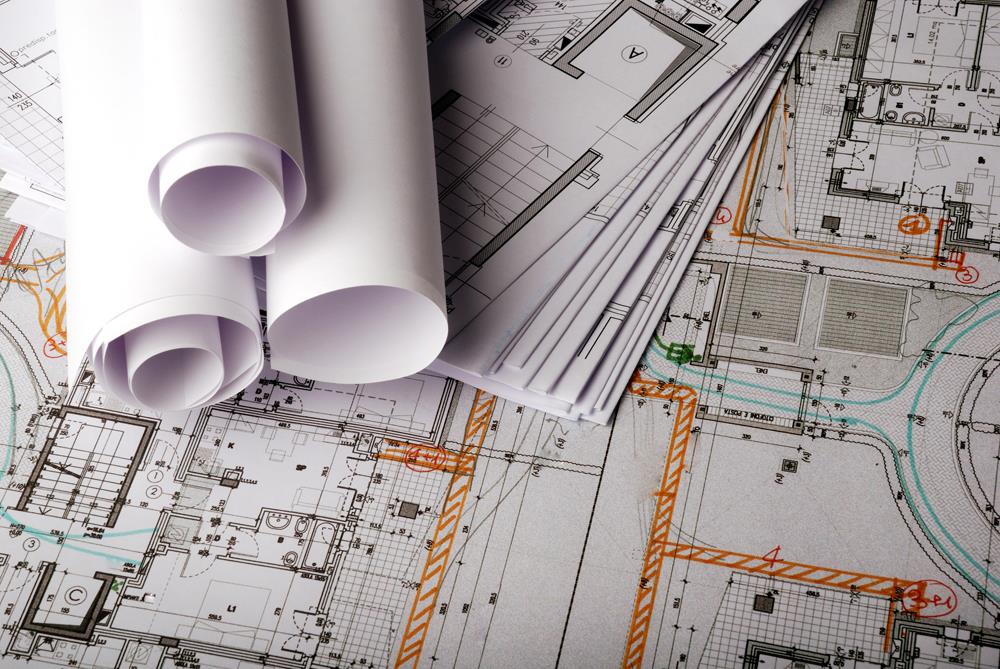Il progetto di ricerca in questione nasce dall’idea di approfondire e valutare l’influenza delle dinamiche territoriali in relazione alle traiettorie di vita individuali di alcuni adolescenti residenti nel quartiere Barca di Bologna.
I processi di spazializzazione delle questioni sociali
I processi di spazializzazione, i quali ricalcano il processo di sovrapposizione tra questione urbana e questione sociale, da un lato, hanno attribuito notevole importanza al territorio come ambito privilegiato di studio delle questioni sociali, dall’altro hanno fatto coincidere lo stesso territorio con dei problemi sociali specifici, quali la povertà, la criminalità e l’esclusione sociale. Pensare alle periferie delle grandi città contemporanee sembra, quindi, comportare un processo di associazione quasi automatico con i problemi che le attraversano o, nella migliore delle ipotesi, con i programmi e le politiche che intendono affrontarli. Inoltre, si cita il processo di «patologizzazione», per cui gli abitanti di tali luoghi da «miserabili» diventano pericolosi e viceversa, riproducendo l’associazione tra povertà e pericolosità sociale in una chiave del tutto territoriale.
«La Haine»
Le politiche territorializzate, in questo modo, diventano dirette esclusivamente alle periferie considerate à problème, comportando delle conseguenze pericolose. È utile una sovrapposizione con il caso francese, in particolare soffermandosi sulle emblematiche banlieues delle principali città francesi (Parigi, Marsiglia, Lione e Avignone), scenari di rivolte e scontri. Nel corso degli anni Ottanta, infatti, si fa strada una nuova problematica socio-urbana, denominata «malattia delle banlieues», che delineava specifiche aree della città con una forte connotazione etnica da distaccare dalle altre zone.
La paura del «ghetto» è tangibile e viene riprodotta dall’opinione pubblica, alimentata da giornali e personaggi politici. È ciò che è possibile osservare nel famoso film «La Haine» del 1995, diretto da Mathieu Kassovitz, che prende spunto dalla reale uccisione di un ragazzo delle banlieues di Parigi da parte della polizia. La pellicola non a caso scosse l’opinione pubblica destando critiche e provocando grandi polemiche in Francia per il suo punto di vista sulla violenza urbana e sulla messa in scena della brutalità della polizia.
Un film per capire il problema
«La Haine» ha in sé la rabbia e la frustrazione dei giovani di seconda generazione che portano avanti le rivolte al fine di riscattarsi, riproduce la visione di una periferia già di per sé dimenticata dalle istituzioni, riducendola a un nucleo sociale che non ha possibilità di riscatto, impantanato nei pregiudizi altrui. Gli abitanti, di conseguenza, vengono classificati come gli ultimi, senza speranze e futuro. È su questa base che si regge l’esemplificazione presentata per cui le forze dell’ordine si sentano autorizzate a trattare questi residenti come qualcosa su cui esercitare potere, restando impuniti. Si assiste evidentemente al distacco e alla distanza tra centro e periferia: la banlieue parigina è un gruppo, una società culturale a sé stante che ha le sue regole, i suoi codici, la sua cultura, che costituiscono già di per sé una barriera tra due realtà.
Il rinnovato ruolo dei quartieri
Nel susseguirsi del dibattito scientifico, appare sempre più imprescindibile chiarire e definire il concetto di «quartiere». Esso va considerato innanzitutto in un senso fisico e spaziale (ecologico) e di organizzazione sociale piuttosto che come forma di solidarietà sociale. Dunque, è da evitare e da superare la sovrapposizione tra quartiere e comunità, le quali definizioni sono separate; si ritiene corretto parlare di potenziale corrispondenza e non più di semplice relazione. Una sovrapposizione di questo tipo potrebbe comportare conseguenze rischiose e fuorvianti, nonché il rischio di considerare nel ritorno alla comunità, in termini nostalgici e ideologici, una sorta di panacea per i mali della società moderna.
Non è possibile, infatti, pensare al declino della comunità come al declino dello spazio. Il concetto di quartiere, perciò, è utilizzabile e in campo sociologico come ambito autonomo di attenzione o come spazio fisico in cui studiare precise dinamiche urbane. È opportuno focalizzarsi sul quartiere non solo in termini scientifici e accademici ma anche a fronte della riscoperta di una dimensione comunitaria in cui la mixité sociale diventa una risorsa preziosa.
La ricerca sul territorio del quartiere barca
L’area statistica «Villaggio della Barca» è soltanto la parte più a ovest di quello che nel corso del XX secolo è andato definendosi come «quartiere Barca». Nel 2016, il quartiere Reno viene unito a Borgo Panigale, dando vita all’unità amministrativa di Borgo Panigale – Reno, collocata nell’estrema periferia ovest di Bologna. Per un anno intero, da gennaio 2022 a gennaio 2023, la scrivente ha avuto modo di osservare da vicino e, sicuramente da una posizione privilegiata, gli adolescenti della Barca e, in particolare, la loro vita intorno al Treno.
L’esperienza lavorativa di chi scrive, come educatrice della Cooperativa Sociale «Società Dolce Società Cooperativa» del Servizio Educativo Domiciliare, ha consentito l’ingresso nelle loro case, nella loro quotidianità e negli spazi della Barca come una residente del quartiere stesso. Nello specifico, si parla di Serena, ragazza all’epoca del primo incontro, avvenuto il 10 gennaio 2022, tredicenne e frequentante le Dozza (nonché l’Associazione Per l’Educazione giovanile e, dall’anno scolastico successivo, il Centro Anni Verdi). Dopo una lunga fase di conoscenza e di costruzione del rapporto di fiducia, Serena ha introdotto la scrivente nei posti più significativi del quartiere, nonché della sua vita, come osservatrice partecipante.
Il quartiere barca e i servizi educativi
Sono state percorse le strade verso le Dozza e verso i servizi educativi pomeridiani, verso i centri sportivi, i parchi e, soprattutto, i portici del Treno; sono stati conosciuti ragazzi e ragazze, giovani adolescenti e giovani adulti, che considerano le suddette strade la loro residenza. Questi ragazzi, con il passare del tempo, hanno riconosciuto e legittimato la presenza dell’osservatrice non considerandola più un’estranea, bensì una figura familiare e ricorrente all’interno del loro spazio di vita. Alla luce di ciò, è possibile affermare che il rapporto di fiducia reciproca costruito con Serena, l’atteggiamento informale, la giovane età e l’estetica che ne deriva, si siano configurati come facilitatori e come caratteristiche peculiari del progetto, nonché come risorse sorprendenti e inaspettate per uno studio approfondito.
È proprio questo il punto da cui inizia il lavoro di ricerca vero e proprio, il quale prevede interviste semi-strutturate agli interlocutori fondamentali, ovvero un gruppo di adolescenti residenti della Barca di età compresa tra i 13 e i 15 anni, e ai due educatori del Centro Anni Verdi e osservazione partecipante delle dinamiche territoriali e relazionali.
Gli obiettivi perseguiti
L’obiettivo principale della ricerca è, quindi, indagare la percezione interna, legata al quartiere Barca e alle sue dinamiche, da parte di alcuni residenti appartenenti ad una fascia di età che, per antonomasia, risulta complessa e di difficile lettura. Dunque, obiettivi connessi sono:
- comprendere e registrare le peculiarità del territorio di ricerca, attraverso la presentazione di dati empirici e quantitativi e l’osservazione sul campo;
- dare voce e spazio ai ragazzi coinvolti raccogliendo il loro punto di vista, i bisogni e le esigenze emergenti;
- presentare la prospettiva esterna degli operatori dei servizi che operano con la suddetta fascia d’età;
- valutare se e quanto influisce «l’effetto quartiere» come concetto prettamente teorico in applicazione concreta nella ricerca sul campo.
I risultati e gli esiti
Per quanto riguarda l’obiettivo principale, l’evoluzione della ricerca ha suggerito che la percezione interna degli adolescenti intervistati rispetto al proprio quartiere è a tratti ambivalente. Essa si connota in modo nettamente positivo in relazione al senso di appartenenza e di identificazione con il quartiere e in modo «ambiguo» in relazione ai servizi, alle attività e agli spazi che esso offre per gli adolescenti, ad eccezione dei luoghi in cui si pratica sport. In base alla prima connotazione, è utile richiamare diversi aspetti emersi dalle parole degli intervistati:
- l’affermazione, condivisa all’unanimità, di non aver mai pensato di voler vivere altrove;
- l’esplicitazione di un forte legame con il proprio quartiere;
- la percezione dei loro coetanei residenti in altre zone, estranei alle dinamiche territoriali interne del proprio luogo di residenza;
- la concentrazione di parole «positive» in riferimento alla descrizione del proprio quartiere.
In base alla seconda connotazione, invece, è possibile citare l’individuazione di due tendenze opposte, per cui tutte le intervistate, tranne una, dichiarano l’assenza di spazi e attività interessanti mentre tutti gli intervistati ne dichiarano la presenza. Per quanto riguarda gli obiettivi connessi, è interessante sottolineare quanto l’osservazione sul campo abbia confermato la particolare implementazione architettonica, caratterizzata da molteplici alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, primo fra tutti l’imponente Treno. Essa ha anche permesso di riscontrare l’importanza e la valenza simbolica attribuita a luoghi specifici, che risultano essere anche i più frequentati dagli adolescenti intervistati: i portici del Treno, il Parco di Piazza Giovanni XXIII, la chiesa di Sant’Andrea Apostolo e il Centro Sportivo.
L’effetto quartiere barca
Per giunta, dalle interviste, sia degli adolescenti che degli educatori del Centro Anni Verdi, sono emerse delle specificità in relazione ai bisogni degli appartenenti alla fascia d’età studiata. Gli educatori registrano e riportano bisogni diversificati in relazione al sesso degli adolescenti e all’età nonché alla frequenza della scuola secondaria di primo grado o di secondo grado, la quale sembra essere una discriminante importante. Infine, una valutazione più complessa è quella che fa riferimento all’«effetto quartiere», approccio per il quale il quartiere in cui si vive possa costituire un acceleratore delle condizioni di svantaggio.
Secondo questo approccio, vivere in un luogo isolato facilita la trasmissione di norme antisociali attraverso l’influenza esercitata dai pari secondo una visione «epidemica» della società. Tuttavia, dalla ricerca non si registra un sostanziale isolamento, fisico e sociale, in quanto gli adolescenti, con l’ingresso nella scuola secondaria di secondo grado, entrano inevitabilmente in contatto con coetanei di altre aree della città e con nuovi spazi territoriali.
Il trasporto pubblico
A questo proposito, è emersa anche l’importante risorsa, in termini di fattore protettivo, rappresentata dal servizio di trasporto pubblico, il quale garantisce la mobilità e la prossimità. Gli intervistati presentano una certa consapevolezza nell’affermare che riconoscono la specificità delle dinamiche interne del proprio quartiere che persone provenienti dall’esterno farebbero fatica a comprendere. Alcuni si dichiarano «diversi» dai propri coetanei in relazione al loro luogo di residenza, altri, con un approccio meno enfatico, riconoscono, ad ogni modo, delle specificità territoriali. Dalle interviste degli operatori emerge in modo chiaro l’influenza delle dinamiche territoriali sulla vita e sull’approccio dei ragazzi.
La fuga degli adolescenti
A questo proposito, gli intervistati richiamano, in primo luogo, due tendenze principali, apparentemente contrapposte ma non autoescludenti: la «fuga» degli adolescenti dalla vita del quartiere per «rifugiarsi» in un posto sicuro e accogliente e il fascino per le medesime dinamiche da cui tentano di rifuggire. Gli adolescenti, infatti, si mostrano consapevoli delle problematiche e della narrazione esterna, a volte stigmatizzante, del luogo in cui vivono. Ciò potrebbe riflettersi in modo negativo sul sentimento di incomprensione e di mancanza di supporto sperimentato dagli adolescenti, il quale si delinea soprattutto in relazione all’ambito scolastico.
Riflessioni conclusive sul quartiere barca
In ultimo, risulta opportuno citare delle possibili traiettorie di intervento che si focalizzano principalmente su un modello operativo che metta in luce e valorizzi le potenzialità dei giovani, da concepire come risorse nei confronti delle quali vi è il riconoscimento di identità intersezionali. Ciò delinea un percorso articolato e complesso, in cui i bisogni e le esigenze sono sfaccettate, per cui si necessita il coinvolgimento di persone appartenenti sia alla rete formale che a quella informale e la creazione di luoghi accessibili e vicini.
È da promuovere la partecipazione attiva dei giovani, anche in termini di cittadini di uno spazio fisico, affinché partecipino alla creazione sinergica di un nuovo e attraente processo di comunità legato, tra le altre cose, alla gratuità del welfare culturale e al superamento della frammentazione dei servizi. L’unica via percorribile rimane quella del cambio di prospettiva, puntando non tanto sulle risposte estemporanee quanto su una strategia politica di lunga durata tesa a lottare contro le disuguaglianze e le forme nascenti di disagio sociale, perché «l’importante non è la caduta ma l’atterraggio».
Maria Mastrocinque
Riferimenti bibliografici e sitografici
- Alaimo A., Arioti E., Pinardi M. (1982), Alcuni spunti per una ricerca storica sul quartiere Barca, Ciclostilati della conferenza sulla ricerca – intervento sui giovani della Barca, Fondo Quartieri-Decentramento, 1963-1990, buste sul Progetto Giovani, Archivio Storico Comunale di Bologna, Bologna.
- Castrignanò M. (a cura di) (2021), Sociologia dei quartieri urbani, FrancoAngeli, Milano.
- Marelli C. M. (2020), La spazializzazione della questione sociale. Politiche urbane prioritarie in Inghilterra, Francia e Italia, FrancoAngeli, Milano.
- Comune di Bologna, www.comune.bologna.it
- https://www.comune.bologna.it/quartieri/borgo-panigale-reno
- https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/centri-anni-verdi
- I numeri di Bologna metropolitana, www.inumeridibolognametropolitana.it
- http://inumeridibolognametropolitana.it/studi-e-ricerche/la-fragilita-demografica-sociale-ed-economica-nelle-diverse-aree-della-citta-3